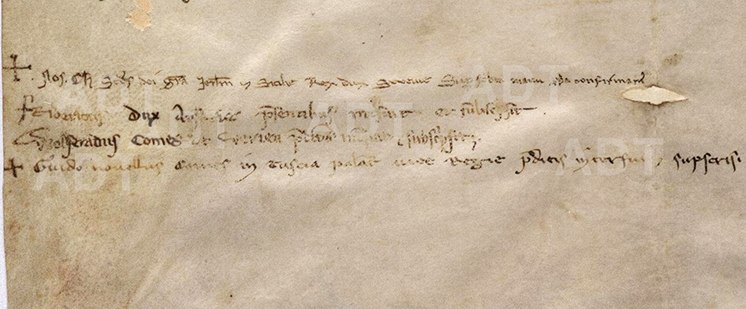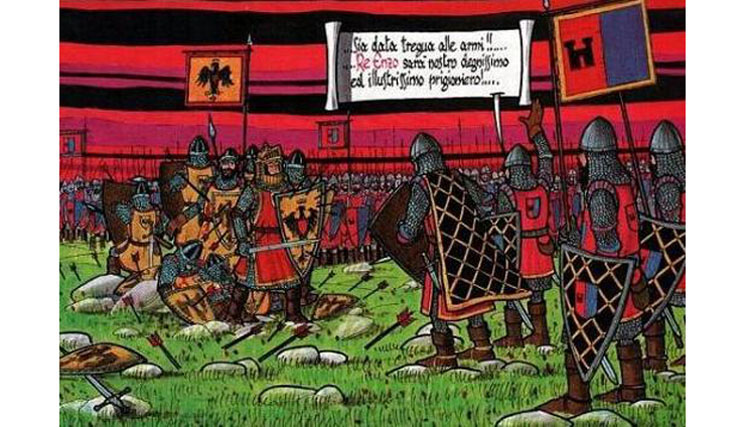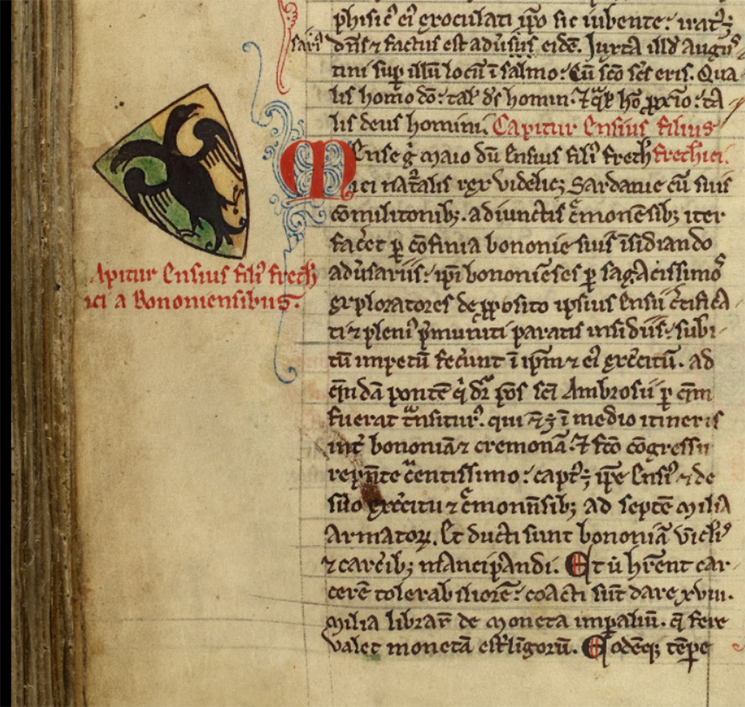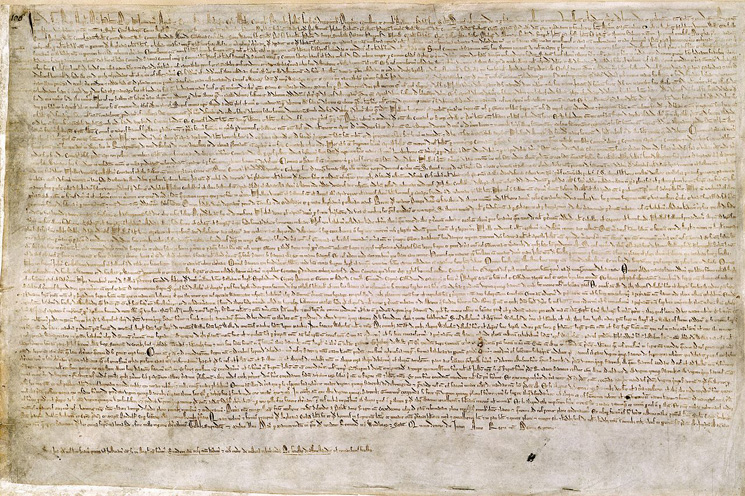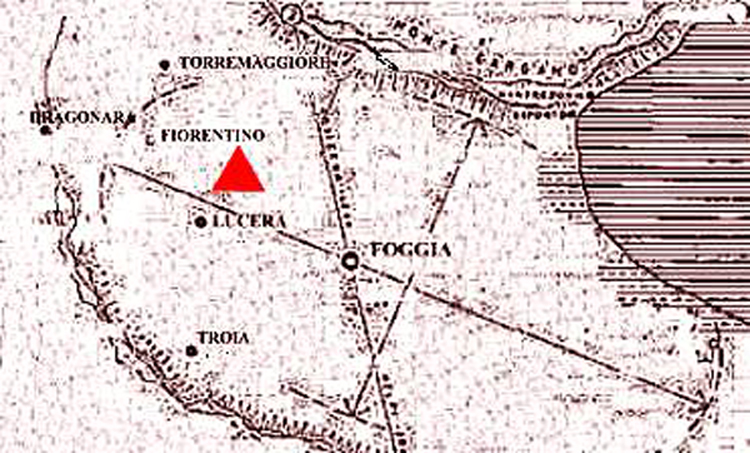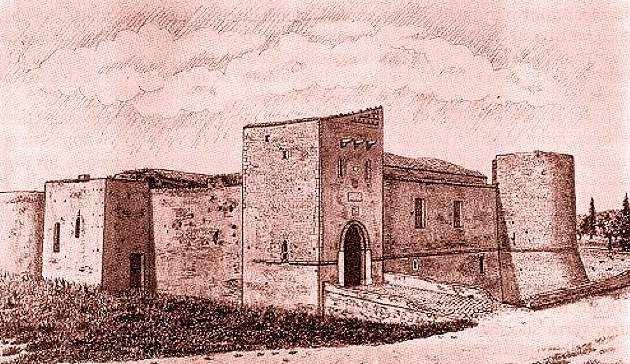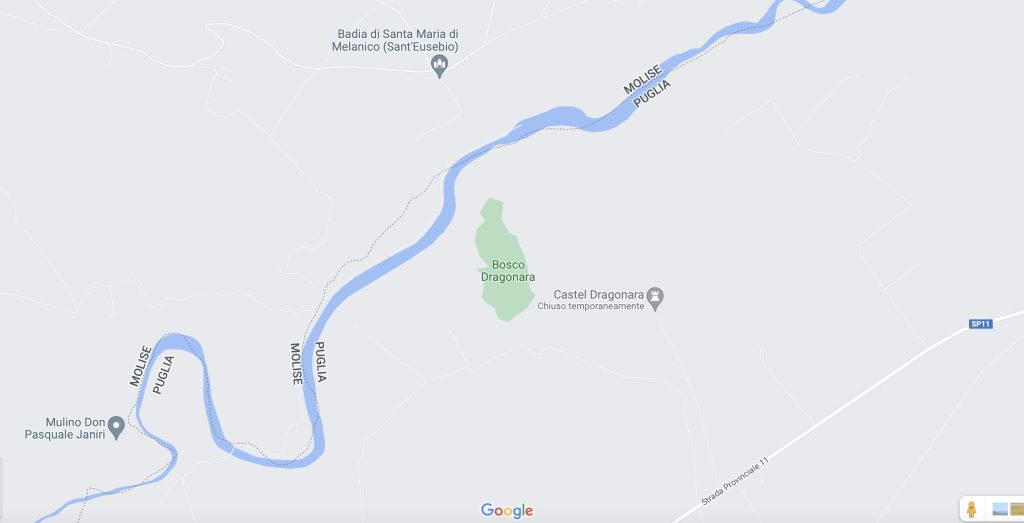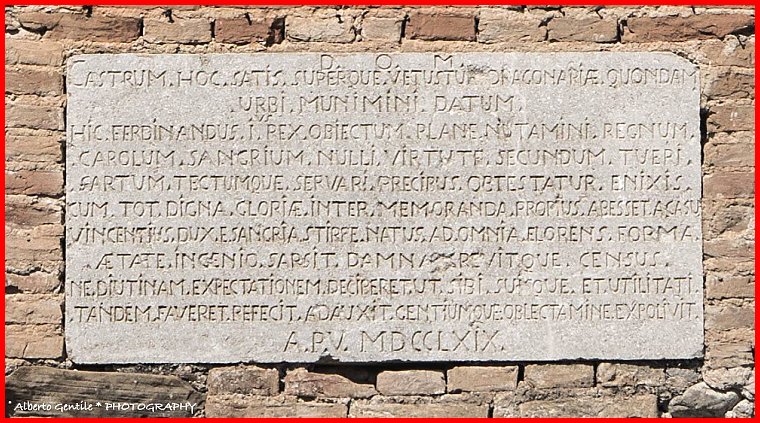L’idea di Medioevo nei capitoli “europei” di Resident Evil.
Introduzione.
Il Medioevo, come diceva Umberto Eco, lo si “rabbercia”. Lo si ristruttura grossolanamente, lo si raffazzona in modo da poter continuare a usarlo come contenitore per le nostre vite, dal momento che il Medioevo ha inventato una vasta gamma di cose con cui stiamo ancora facendo i conti. Il fenomeno è stato osservato per ogni aspetto possibile, materiale e immateriale: chiese, palazzi comunali, monumenti, film, serie tv, romanzi, fumetti e chi più ne ha più ne metta. Ma come si rabbercia il Medioevo, o meglio il sogno di un Medioevo, in due videogiochi che parlano di zombies, vampiri e lupi mannari ambientati in Europa?
Wu Ming, nel suo romanzo Ufo 78, asserisce che l’obiettivo di uno scritto è raccontare la verità, sia pure parlando di dischi volanti e lupi mannari; dunque, il sogno di un Medioevo in dei videogiochi che parlano di morti viventi e lupi mannari si analizza, a modesto parere di chi scrive, innanzitutto raccontando la verità, storicizzando le opere.
Resident Evil 4 e Resident Evil: Village sono due videogiochi del genere action-horror pubblicati dalla celebre casa nippo-statunitense Capcom. I titoli sono ambientati in piccoli centri isolati di due Paesi europei, rispettivamente la Spagna e la Romania, per fornire il pretesto alla trama (completamente cinematografica) comune a tutta la saga: l’incidente che trasforma un’intera comunità in zombies, che vengono combattuti da eroi “quotidiani”. Il primo titolo, sebbene sia stato oggetto di un ottimo remake lo scorso anno, è in realtà uscito, nella sua versione originale, nel 2004. Il secondo titolo è di parecchio successivo al primo (2021), ma ne raccoglie per molti versi l’eredità, come stiamo per vedere.
Una delle cose inventate dal Medioevo che ci angoscia ancora ai giorni nostri è il terrorismo mistico: da quando è esplosa la polveriera mediorientale e le organizzazioni terroristiche moderne hanno iniziato a pullulare, figure come la setta degli Assassini e il Veglio della montagna hanno suscitato tutta una serie di riflessioni tagliate con l’accetta riguardo a una naturale quanto lombrosiana propensione di determinate popolazioni a svolgere il mestiere di sicario, per la precisione di sicario fanatico. Tali sforzi speculativi hanno poi contribuito, nel sentire comune, a fornire una grossa base di consensi per chi li ha utilizzati per fini politici, evocando invasioni e sostituzioni etniche. Qui ci sarebbe da parlare parecchio, ma noi ci atterremo all’argomento.
Nel 2004, anno di uscita del primo videogioco preso in esame, si era nel pieno dell’operazione Iraqi Freedom, durante la quale si cercavano ipotetiche armi di distruzione di massa che i terroristi avrebbero voluto utilizzare contro “i crociati occidentali”. La Francia, isolandosi, oppose una chiusura alla richiesta di partecipazione al conflitto, scatenando una reazione stizzita oltreoceano che arrivava a vette vertiginose, come gli spot pubblicitari che invitavano a non acquistare automobili francesi o a mutamenti linguistico-culinari come l’innovativo “freedom fries” al posto di “french fries”, le patatine: la guerra si combatteva su ogni fronte. Fra i sostenitori dell’intervento armato, i cosiddetti “falchi”, serpeggiava la livida connotazione di “amico dei terroristi islamici”, riferita a chi sosteneva posizioni per così dire meno massimaliste. Si era sull’onda emotiva dell’attentato al World Trade Center, d’altra parte, e, nel 2004, il Giappone mandò in Iraq un battaglione denominato “Self-Defense Forces Iraq Reconstruction and Support Group”. Sulla carta, il contingente aveva scopi umanitari, ma fu così chiamato per aggirare l’articolo 9 della Costituzione giapponese. Al-Zarkawi, nello stesso anno, intimò al governo giapponese di ritirare le proprie truppe. Fu il primo dispiegamento militare nipponico all’estero dopo la Seconda guerra mondiale.
Noi ci fermeremo qui, perché di sogni, nello spazio di una cartella editoriale, ne abbiamo sciorinati parecchi: il sogno, se dura troppo, diventa coma profondo e, come scriveva Raffaele Licinio, nel coma, i sogni diventano incubi.
- Chiusure medievali e Parassiti di Distruzione di Massa
Come punto di partenza, prenderemo il quarto capitolo della saga nel suo remake del 2023.
Ci troviamo a Valdelobos, un paesino rurale sperduto su montagne non meglio precisate della Spagna, in compagnia di due poliziotti che sembrano incarnare uno dei clichés più longevi della letteratura mondiale: l’impiegato pubblico scansafatiche.
Il protagonista è il superpoliziotto statunitense Leon S. Kennedy, in missione per salvare Ashley, la figlia del Presidente degli Stati Uniti. La ragazza è stata rapita da una setta, che ora chiede un riscatto. Leon è sopravvissuto all’incidente di Raccoon City (Resident Evil 2), rimanendone fortemente scosso, e proprio per questo è stato inserito in un programma di addestramento militare estremo.
Il nostro eroe, rimasto solo, si inoltra in un villaggio coperto di erbacce selvatiche, costituito da stamberghe fatiscenti e luride abitate da una popolazione dagli sguardi febbrili e dai movimenti trascinati, che lo attacca violentemente urlandogli contro «forastero», “sconosciuto”. A parte imbarazzanti rassomiglianze cinematografiche (innanzitutto The wicker man del 1973), cosa succede?

Per fortuna, abbiamo una spiegazione: Incubate (bel gioco di parole tra l’incubo di cui sopra e l’incubazione di una malattia) è un film in computer grafica uscito in accompagnamento dell’edizione originale del 2004 di Resident Evil 4, che racconta di Valdelobos con il classico espediente del diario scritto da un dissidente. Si tratta di un paesino montano isolato e chiuso, nel quale fa il suo avvento lord Saddler, capo della setta degli Illuminados. La filosofia degli abitanti di Valdelobos è quella di stare il più lontano possibile dalla modernità e dalla tecnologia, adottando uno stile di vita rustico e semplice, per molti versi simile a quello dell’età preindustriale, con i suoi riti e i suoi ritmi.
Saddler (che, come ogni villain che si rispetti, parla con accento britannico) li convince però che è necessario purificare il loro sangue e le loro anime e, casualmente, ha con sé “il dono”, la cura che li renderà più forti e puri: dei parassiti, Las Plagas. Gli abitanti, a farla breve, si tramutano in una specie di zombies rimbambiti e aggressivi, ma il parassita non riesce a adattarsi al corpo dei bambini del villaggio, che muoiono tutti. Sebbene l’espediente abbia la sua ovvia funzione morale, perché nessun giocatore vorrebbe far saltare la testa a dei poveri pargoli malati, anche questo è un déja-vu: nelle epidemie di peste del Trecento, molti bambini infettati morivano perché tra un’epidemia e l’altra passava parecchio tempo, e i più piccini non erano immunizzati. Lo stesso nome del parassita, Las Plagas, è palesemente un calco dall’inglese plague: peste, piaga.
Dopo aver fatto la sgradita conoscenza dei primi residenti, Leon si ritrova ben presto davanti alla scena madre di ogni rappresentazione di un Medioevo buio: il rogo.

I contadini cercano allora di uccidere Leon, in quella che sembra una trasposizione videoludica della famiglia Hellequin, con tanto di gigante armato di clava. La caccia selvaggia si protrae per varie fasi del gioco, mentre Leon perde e ritrova più volte Ahsley in un purgatorio itinerante spasmodico.

Praticamente sovrapponibile risulta la trama dell’ottavo capitolo, Village, in cui un altro eroe ombroso e americano deve salvare una figlia “speciale” (stavolta la sua Rose) da orde di esseri mostruosi mutati da un parassita.
Il protagonista è Ethan Winters, un uomo comune che si trova in Romania con moglie e figlia neonata grazie a un programma di protezione della BSAA, un ente ONU che si occupa di bioterrorismo. Ethan è sopravvissuto ai macabri fatti del settimo episodio della saga, ambientato in Louisiana: ancora una volta, un eroe dal passato travagliato.
Come recita il titolo, l’avventura si svolge in un anonimo villaggio rumeno sperduto tra i monti, isolato come Valdelobos, governato da una struttura di potere matriarcale (gli antagonisti maschili sono immaturi, impulsivi e trattati con sufficienza dalle donne) che richiama vagamente un sistema feudale: la signora Madre Miranda, alata come un serafino greco e provvista di un’aureola rigida, controlla il villaggio con il terrore insieme ai suoi quattro baroni, dei quali citeremo solo Alcina Dimitrescu, giunonica vampira di due metri e mezzo vestita in stile Belle Époque. Sono esseri mutanti loro stessi, grazie al “cadou”, il “dono” del parassita Megamicete, e capeggiano legioni di licantropi, vampiri e altre creature del genere, cioè i popolani sottoposti alla medesima iniezione salvifica elargita da Madre Miranda.


Ethan è un americano che ficca il naso in un posto in cui non dovrebbe essere (ma guarda un po’…) e allora i cinque “signori” si contendono la sua sorte, sprofondandolo nelle viscere della roccaforte, dove si compie la rituale “caccia selvaggia” da parte dei licantropi. Dopo fasi di gioco rese ancora più rocambolesche dalla visuale in prima persona, Ethan si ritrova prima nel castello e poi nuovamente nel villaggio, costretto a seguire percorsi da criceto prodotti dagli sbarramenti costruiti dalla popolazione sana residua.
Le case del villaggio, pur spoglie e semi dirute, non sono però coperte di escrementi e lerciume e non vi si trovano resti di cibarie tossiche, come in quelle di Valdelobos. Tra gli abitanti ce ne sono per l’appunto alcuni non ancora trasformati, che si riuniscono nell’unica dimora sicura, pregando Madre Miranda con litanie pagane, chiedendole la salvezza. Sono donne e uomini miti, accoglienti e depressi, al punto di cedere all’alcol per fuggire da una realtà allucinante, paradossalmente peggiore della mutazione. Insomma, chiudersi davanti a una minaccia non serve a nulla; anzi, può solo peggiorare la situazione.
La narrazione è però arricchita di alcuni elementi singolari. Ad esempio, l’avventura si apre con un piccolo gioiellino metaletterario: una fiaba animata vera e propria, con tutti i suoi elementi, che anticipa la trama del gioco. Una bambina, incurante del divieto, si allontana nella foresta, dove incontra tre aiutanti (un pipistrello che le dona del nettare, un ragno che le tesse un vestito di seta, un pesce che le dona una scaglia) e un trickster, un cavallo con un ingranaggio sulla fronte. La bimba prende l’ingranaggio dalla fronte del cavallo inchinato, cadendo nel tranello, e l’equino la consegna all’antagonista, Madre Miranda. Ma ecco il co-protagonista entrare in scena: è il padre-eroe che alla fine accetta la lotta e si sacrifica, permettendo alla figlia di salvarsi insieme alla madre.
2. Sto sognando come te un castello che non c’è
Gli scenari di entrambi gli episodi, come è facilmente immaginabile, non possono prescindere dall’elemento principe di ogni ambientazione neogotica: il castello.
Sull’enorme maniero di Resident Evil 4 sembra essersi posato lo stesso ufo planato su Castel del Monte. La struttura si configura infatti come il contenitore unico, nel suo involucro tetro e mastodontico, di tutti i luoghi comuni di antico regime, e dunque del feudalesimo e del Medioevo: lo sfarzo e la pulizia dei pavimenti tirati a lucido dei saloni contrapposti agli ambienti miseri e lerci del villaggio appena lasciato; la completa assenza dei contadini infetti, esclusi dagli ambienti protetti del potere, contro la massiccia presenza di clero e nobiltà (Salazar e i suoi deformi accoliti), unici a godere degli agi di un’abitazione di pregio; il buio di saloni enormi e sprovvisti di finestre adeguate appena rischiarato da lampadari e candelabri mastodontici.

Ci verranno incontro lugubri monaci armati di balestre e catapulte dai proietti infuocati, mazze, scudi e altre armi da mischia; giganti da abbattere a cannonate prima che vi tirino dietro ogni pietra del castello; parassiti disgustosi che si muovono in autonomia o infestando monaci, cani e anche armature cinquecentesche.
Si passerà dai camminamenti di ronda e dai torrioni esterni agli ambienti interni forniti di mobilia e suppellettili raffinatissime, nonché di straordinari rompicapi rappresentati sotto forma di bassorilievi, insegne e serrature cervellotiche. Si arriverà negli immancabili sotterranei colmi di strumenti di tortura farlocchi degni di un museo nazional-popolare e di creature mostruose, per giungere alle ambientazioni da Reggia di Caserta, decorate di stucchi, dipinti e biblioteche. L’intera fortezza si configura come una labirintica scatola cinese, a tratti claustrofobica, a tratti magnifica, in cui il giocatore fa un tour completo dei secoli che vanno dal XIV al XVIII in un’inversione di paradigma del castello disneyano: le attrazioni sono infatti sostituite da sfide mortali, gli indovinelli da enigmi ansiogeni, i personaggi da mostri, la meraviglia dal senso di terrore. La ricostruzione fantastica del gioco ne muta solo la funzione, mantenendo intatta l’immaterialità di fondo del costrutto.


Lo stesso discorso vale per l’ottavo capitolo.
Nuovamente, in tutto il gioco troviamo ambientazioni medievaleggianti, stavolta coadiuvate dalla cornice dell’inverno nevoso di montagna. Vi sono però alcune differenze che, secondo il modesto parere di chi scrive, costituiscono dei miglioramenti.
Le rovine della fortezza, tana dei lupi mannari, sono sufficientemente verosimili, così come gli esterni del castello Dimitrescu, sebbene siano infestati di creature alate simili a gargoyles (sorte inaspettata per dei doccioni) in carne e ossa. Anche gli interni del castello, per quanto ormai ristrutturati in un pesantissimo stile barocco buio e ridondante, sono molto più piccoli e soprattutto sono ripartiti in maniera logica e coerente con gli esterni. Gli ambienti non presentano elementi bizzarri come trenini per il trasporto interno o montacarichi azionati da ingranaggi improbabili, come accade nel maniero spagnolo, e non sono stati disegnati come il solito castello di un vampiro qualunque: c’è il tocco femminile della lady.


Nei sotterranei, di contro, gli sviluppatori si sono sbizzarriti: all’inizio sembrano sobrie strutture ipogee in materiale laterizio smangiato dai secoli e dall’umidità, piene di mobilia in disuso accatastata e cantine polverose; tuttavia, ci si imbatte ben presto nei consueti strumenti di tortura abbandonati e addirittura in una stanza in cui si procede immersi nel sangue fino alla cintola, tra le imprecazioni terrorizzate del protagonista costretto a impallinare vampiri famelici incappucciati e armati di spade e asce da negozio di souvenir sammarinese. Risulta poi particolarmente divertente notare come il parassita sembri mutare gli abitanti in base a un immaginario cinematografico molto distante dal contesto cronologico e geografico: un gigante ipernutrito ricorda più un lottatore di sumo che il diavolo di Cuenca, e Vlad Tepes ha ottenuto la sua fama di vampiro in tempi più vicini al suo successo a Hollywood che al XV secolo, periodo al quale gli sviluppatori hanno ancorato l’immaginario del villaggio anonimo in questione.
3. Lo stereotipo come regola
A partire dal quarto capitolo, assistiamo a una rivoluzione nella saga. I primi tre episodi erano infatti ambientati in America, nell’area dell’immaginaria Raccoon City, e il parassita era il classico virus fuggito da un laboratorio segreto. I luoghi dei primi tre capitoli, ancora una volta isolati e montani, vengono cancellati per sempre da un’arma che nell’immaginario nipponico deve risultare ancor più risolutiva del normale: la bomba atomica.
Il Medioevo post-apocalittico, la distruzione di ogni ordine sociale e delle regole del vivere civile, non c’è più. La peste, dal quarto capitolo, si riprende il suo mondo di riferimento originale: l’Europa di antico regime.
In effetti, almeno per quel che riguarda il quarto capitolo, non sappiamo quanto sia giusto parlare di Medioevo: la parola non esce praticamente mai, né dalla bocca di Leon, né da quella degli altri personaggi. Semmai, ci sono delle interessanti citazioni del Don Quijote, in spagnolo, quando si incontra il controverso Luis Sera, un NPC[1]. Leon e Luis sono due personaggi quasi speculari, che si spalleggiano in un gioco di luci e ombre: eroe traumatizzato ma integerrimo il primo, antieroe castigato e in cerca di redenzione il secondo. Nella cornice di Cervantes, il senso del dovere granitico dell’uno e la sbruffoneria loquacissima dell’altro si configurano come una bislacca controfigura letteraria, con tanto di Dulcinea del Toboso.

Non mancano altri clichés abbastanza scontati: il luogotenente di Saddler è abbigliato come un prete cattolico seicentesco, salvo avere tutti i capi in cuoio da vero duro e, proprio quando lo si incontra, Leon libera un lupo da una nefandissima trappola “medievale”. L’animale, a suo modo, lo ringrazia: la bestia per antonomasia viene redenta con patetica empatia (“take care of yourself, buddy“) dal moderno eroe salvifico. Americano, ça va sans dire.
Lo scontro finale con l’antico regime si ha con il duello tra Leon e il castellano Salazar, il quale, dopo aver insultato diverse volte il protagonista (“non sei per niente un buon cavaliere” – un altro stereotipo – gli dice ad esempio, una delle tante volte in cui Leon perde Ashley), quasi a sottolinearne l’alterità, si becca due pallottole con un americanissimo “you talk too much”: l’eroico uomo d’azione a stelle e strisce cancella un passato logorroico e corrotto, cavia per l’esperimento di Saddler; un “altrove negativo” infestato da una pestilenza perenne, un microcosmo arretrato asservito a un monarca assoluto che lo governa tramite il male.
Leon, salvando la figlia del Presidente dall’orda dei morti viventi, diventa uno dei miti americani per eccellenza: ascende al Valhalla della Greatest generation ever, quella che salvò l’Europa dalla barbarie nazifascista, rassomigliando molto a una specie di Captain America scongelato in un altro contesto.

L’Europa, checché ne dica la Francia, deve ricambiare il favore.
Lievemente diverso, per quanto praticamente congruente, risulta l’impianto narrativo dell’ottavo capitolo, nel quale vediamo popolani non ancora infetti e addirittura alcuni che sono riusciti a fuggire altrove, lasciando le loro catapecchie sbarrate. Gli altri devono difendersi a fucilate da orde di licantropi che li usano come dispensa vivente, pur pregando tutti insieme Madre Miranda nell’unica casa sicura del villaggio, dove si rifugiano quando escono i mostri. Le ambientazioni, per quanto meno campate in aria, trasudano neogotico da tutti i pori, a cominciare dalle teste ci caprone appese un po’ ovunque tra i vicoli. Grottesca risulta la figura del “duca”, nobiluomo parecchio corpulento e decaduto al punto di dover fare il mercante, che svolge la funzione dell’aiutante e, alla fine, conduce sul suo carretto Ethan allo scontro finale, quando ormai l’eroe sembra spacciato.


In Village, inoltre, si ha una menzione del Medioevo direttamente dalla bocca del protagonista, e la cosa accade in una cornice ancora una volta molto più accurata rispetto all’ambientazione del quarto capitolo. Dopo aver sconfitto Alcina Dimitrescu, Ethan incontra una vecchia strega in una cappella sotterranea, tutta adorna di icone della madonna e candele di sego. La strega gli dice che per salvare sua figlia deve recuperare tutti e quattro i contenitori nei quali è stata suddivisa dai duchi cattivi (con un piccolo sforzo si può addirittura pensare al miracolo di una delle leggende agiografiche di san Nicola di Bari) e l’americano, dopo uno scambio di battute immaginabile, proferisce “medieval bullshit”, “stronzate medievali”: la classica espressione con cui ci si riferisce a tutto ciò che di irrazionale e credulone proviene da un passato andato, lontano, obsoleto e ovviamente superstizioso; un’espressione, “medieval bullshit”, che può essere applicata praticamente a tutto, senza perdere la sua efficacia rappresentativa e mantenendo la sua autorevolezza proprio nel menzionare quell’aggettivo, “medieval”, che è diventato ormai il contenitore di ogni stupidaggine possibile. Per uscire da quel Medioevo buio, bigotto e ingiusto bisogna seguire la direzione indicata dal dito puntato dello zio Sam, insomma. Tutto ciò che è da cassare, da rimodernare, da ristrutturare o addirittura da radere al suolo proviene dal Medioevo. Un Medioevo che è rimasto stigmatizzato in una cultura che ha avuto sì il suo, ma l’ha chiamato in un altro modo.
Nota bibliografica
Per il sogno del Medioevo ci si è riferiti a Umberto Eco, Dieci modi di sognare il Medioevo, tratto da Sugli specchi e altri saggi, Milano 1985 e Raffaele Licinio (a cura di), Castel del Monte. Un castello medievale, Bari 2002, Premessa.
Per le ambientazioni orrorifiche medievali e le loro corrispondenze nella letteratura specifica e nelle fonti, si veda Vito Fumagalli, I paesaggi della paura. Vita e natura nel Medioevo, Bologna 2001, pp. 31-34 e 37-39. Si veda anche, dello stesso autore, Quando il cielo s’oscura, Bologna 1998, in particolare pp. 24-29 e 64-65.
Fondamentale anche la lettura di Piero Camporesi, Il pane selvaggio, Milano 2016, in particolare p.23 ss; 85-86; 134 ss.
Per la famiglia Hellequin e le superstizioni in generale, Orderico Vitale, Historia Ecclesiastica, Lib. VII., Londra 1864 e Jean-Claude Schmitt, Medioevo superstizioso, Bari 1992, p. 126 ss. e passim.
Per la caratterizzazione del lupo tra antichità e Medioevo, cfr. Gherardo Ortalli, Lupi genti culture. Uomo e ambiente nel Medioevo, Torino 1997, pp. 57-83. Notare che lo stesso nome del villaggio di Valdelobos richiama il lupo, animale padrone delle valli in cui sorge l’abitato, rendendolo un luogo spaventoso anche nella toponomastica.
Per l’idea di Medioevo in generale, si vedano Francesco Violante, L’età dimezzata. Il Medioevo come stereotipo tra ricerca e didattica, in AA.VV., Il Mezzogiorno medievale nella didattica della storia, a c. di Raffaele Licinio e Tommaso Montefusco, Bari 2006 e Giuseppe Sergi, L’idea di Medioevo, Roma 2005. Per la caratterizzazione negativa a priori del Medioevo, anche a livello giornalistico, G. Sergi, op cit. p. 22.
Per gli effetti degli ufo sui castelli, si veda Raffaele Licinio (a cura di), Castel del Monte. Un castello medievale, Bari 2001, Premessa.
Per il concetto di “alterità nell’alterco” cfr. Massimo Arcangeli, Senza parole. Piccolo dizionario per salvare la nostra lingua, Milano 2020.
Per il Medioevo “americano”, la sua differente accezione nella cultura d’oltreoceano e la percezione dello stesso nella cultura mainstream, si veda Gabriella Piccinni, I mille anni del Medioevo, Milano 2002, p. 434 e passim.
Tutte le immagini sono state tratte dai videogiochi originali tramite il sistema di cattura schermo di PlayStation 5.
[1] Data la nequizia dei tempi, occorre specificare che NPC sta per Non Playable Character, personaggio non giocabile, niente a che fare con i balletti dai movimenti stereotipati tanto in voga oggigiorno sui social media. Tali espressioni artistiche vanno sotto il nome di NPC per ragioni completamente ignote a chi scrive.